Marco Delsante è un dottorando presso la facoltà di Nefrologia dell’Università di Parma. Lui negli Usa è un po’ di casa visto che per due anni ha lavorato presso l’Università Johns Hopkins di Baltimora, una delle più importanti e produttive università americane. In un seminterrato dell’Università parmense Delsante ha il suo piccolo laboratorio di ricerca dove è ritenuto tra i migliori nella diagnosi delle malattie del rene. Ha studiato per quasi quindici anni con l’obiettivo di evitare che il paziente vada in dialisi o, nella peggiore delle ipotesi, abbia bisogno di un trapianto.
Ma anche quando questo dovesse avvenire, l’obiettivo del suo gruppo è fare in modo che quel trapianto duri per tutta la vita del paziente. Quello che sembra banale osservando gli strumenti tecnologici a disposizione (tra cui un microscopio a fluorescenza che evidenzia la presenza di proteine alla base di alcuni danni al rene), nella realtà è reso complicato dal fatto che spesso le malattie del rene non hanno sintomi ben precisi e non tutti i processi sono ben noti alla scienza.
Ecco perché la ricerca in questo campo è fondamentale: permette di capire quali sono i meccanismi all’origine del problema renale e quindi prevenirlo. Per fare tutto questo l’Università lo paga poco più di mille euro al mese. Per la precisione 1150. Non è una vittima del sistema, o almeno non l’unica. Condivide la sua condizione con migliaia di ricercatori che scelgono il lavoro accademico dopo la laurea, ossia la strada del dottorato di ricerca: tre anni in condizioni economiche da lavoro povero.
“È un percorso che fa chi se lo può permettere”, spiega Delsante e allude alla possibilità che mamma e papà integrino il reddito del ricercatore, cosa che riguarda anche lui. A 34 anni e dopo una laurea con 110 e lode non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi a quei 3400 dollari al mese che gli versava l’università americana, e questo quando non aveva ancora concluso il percorso formativo.
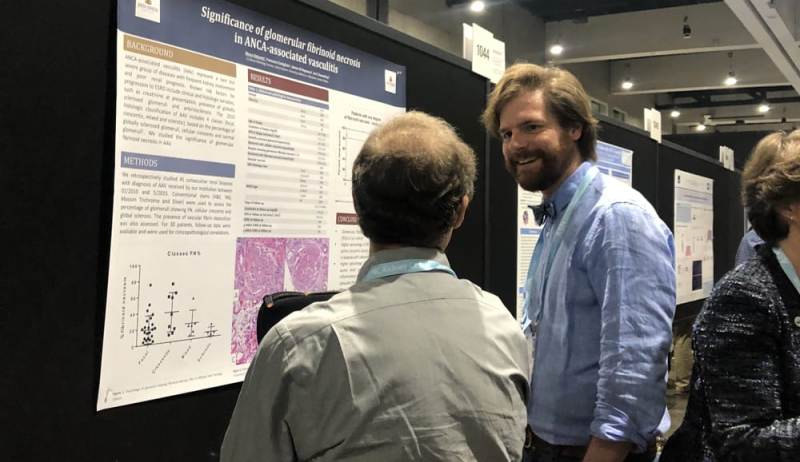

“Non ho una mia famiglia e questo mi consente di vivere dignitosamente, ma molti miei colleghi che hanno fatto la scelta opposta si sono trovati davanti a un bivio: rinunciare alla ricerca o andare all’estero”. La domanda spontanea è perché non sia rimasto negli Stati Uniti e la risposta è delle più ideologiche: “Non volevo lavorare per il sistema sanitario americano, non lo ritengo equo. Volevo lavorare per migliorare quello italiano che è molto più giusto, tanto più che ho potuto constatare che non abbiamo niente da invidiare né da un punto di vista clinico, né formativo e né personale”.
Ottimi principi che presuppongono grande resistenza a tutto ciò che comporta un lavoro povero. Non a caso, tra ampolle, microscopi e provette, nel suo laboratorio campeggia l’icona di Howard Miller, la donna operaia che rimboccandosi le maniche e mostrando i muscoli dice: “We can do it”. Qui la sua video intervista al Corriere.
Ti potrebbe interessare anche: Così Salvini permette ai mafiosi di ricomprare i beni confiscati. Chapeu
